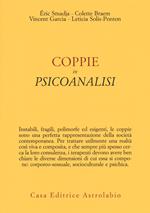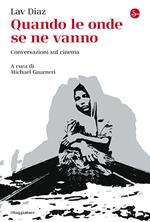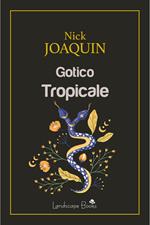La letteratura filippina è una voce in costante espansione. In essa convivono arcaicità orale e avanguardia, mito e postcolonialismo, radicamento locale e slancio interculturale. È una letteratura fatta di fratture, ma anche di sorprendenti ricomposizioni: una voce che attraversa i secoli inseguendo il diritto a raccontarsi.
Prima della colonizzazione, le Filippine erano attraversate da una vivace e articolata tradizione orale, tramandata in una molteplicità di lingue austronesiane. Canti epici, poemi rituali come l’Ambahan e il Dalit, proverbi, miti e leggende costituivano l’ossatura di una cultura performativa e collettiva, capace di trasmettere la memoria dei clan, l’etica comunitaria e una visione del mondo in profonda armonia con la natura e il soprannaturale. Con l’arrivo degli spagnoli nel XVI secolo, la scrittura diventa invece uno strumento di potere coloniale: si diffonde una letteratura religiosa e didattica, redatta in spagnolo o nelle lingue locali ma traslitterata con l’alfabeto latino, spesso promossa dai missionari. Tuttavia, nel XIX secolo si sviluppa una contro-narrazione, una letteratura di resistenza politica che segna l’emergere di una coscienza nazionale.
Tra le figure più emblematiche, José Rizal (1861-1896), autore di Noli Me Tangere (1887) e El Filibusterismo (1891), denuncia le ingiustizie del sistema coloniale e ispira i primi movimenti indipendentisti. Accanto a lui si distinguono anche Marcelo H. del Pilar (1850-1896), considerato de facto un eroe nazionale, e Graciano López Jaena (1856-1896). Insieme erano conosciuti come il “Triumvirato filippino”. È in questo periodo che nasce l’idea moderna di una letteratura impegnata, al servizio della nazione e della libertà.
Dopo la guerra ispano-americana (1898), le Filippine entrano sotto il dominio statunitense. L’inglese viene imposto come lingua ufficiale e strumento educativo. Nasce così una letteratura anglofona, inizialmente imitativa dei modelli occidentali, ma poi sempre più consapevole. Tra gli esponenti di questa fase, ricordiamo Nick Joaquin (1917-2004), autore emblematico del secolo, elabora un barocco meticcio che fonde mitologia locale, eredità cattolica e atmosfere gotiche.
Con l’indipendenza (1946), la letteratura si confronta con il trauma coloniale, la memoria della guerra e la lotta per la definizione dell’identità. Nascono voci forti sia in inglese che in filippino, spesso in tensione tra globalismo e radici popolari.
Al giorno d'oggi la letteratura filippina si distingue per la sua multidimensionalità e vivacità; è globale, plurilingue, postmoderna. Autori locali e della diaspora pubblicano in inglese, tagalog, cebuano e altre lingue regionali, affrontando i temi della dislocazione, del corpo, della memoria e dell’identità queer.
Tra gli autori contemporanei, ricordiamo Miguel Syjuco, vincitore del Man Asian Prize, Gina Apostol, che intreccia architetture narrative complesse e sguardi storici.