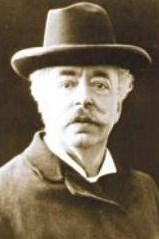Edmondo De Amicis fa parte di quella letteratura di comune conoscenza, dalle cui opere è difficile che gli italiani (almeno quelli della generazione che ora volge al tramonto) non abbia tratto nel corso di conversazioni qualche espressione, qualche nome, qualche metafora o frase idiomatica. Chi non ha mai citato frasi dall’amore di Francesca da Rimini di Dante (“l’amor che a nullo amato amar perdona !”), o dalla “Cavallina storna” di Pascoli, o dagli episodi di Don Abbondio di Manzoni (“il coraggio, chi non ce l’ha non se lo può dare”) o….da Alberto di Giussano di Giosuè Carducci (“or si fa innanzi Alberto di Giussano!”) ? Di Edmondo De Amicis, sono solitamente noti pezzi del famoso libro Cuore: l’alunno cattivo Franti; il viaggio dagli Appennini alle Ande; la maestrina dalla penna rossa…. Poco conosciuti sono invece i suoi Ricordi d’un viaggio in Sicilia, scritti agli inizi del Novecento; da ascriversi a quella ampia letteratura di viaggiatori in Sicilia, iniziata nel Settecento e comprendente nomi come John Dryden Jr , Patric Brydon , Avram Sergeevic Norov ecc. Il volume di Carducci con i suoi ricordi sulla Sicilia è stato edito a Catania nel 1908, quando l’autore era già vecchio, dall’editore “Cav. Niccolò Giannotta, libraio della Real Casa” ed inizia con questa dichiarazione: “Non avevo più visto la Sicilia da quarant’anni, niente di meno: dall’anno di grazia 1865, nel quale avevo fatto la mia prima guarnigione, come si dice in linguaggio militare, nella città di Messina, da dove ero partito col mio reggimento nell’aprile del 1866 per la guerra contro l’Austria. E fu appunto Messina la prima città che rividi venendo da Roma…” Quindi, dopo un richiamo alla storia di Messina, sin dalla sua fondazione (“i pirati di Cuma e di Calcide che la fondarono; i cartaginesi, i romani, i saraceni, i normanni, gli spagnoli, i francesi e l’entrata trionfale di Garibaldi del 1860) la descrizione della Sicilia prosegue col viaggio da Messina a Palermo, in cui, più che dei luoghi, di cui è suggestiva la descrizione dei tratti lungo il mare, in vista delle isole Eolie “che pare sorgano l’una dopo l’altra dalle acque, con le loro belle forme vulcaniche, ardite e leggere, tinte di colori soavi”, dei boschetti d’aranci e siepi di fichi d’India e le spalliere di àloi, gruppi di palme “accarezzate e mosse da un’aria imbalsamata”, sembra che l’Autore sia colpito soprattutto dal carattere dei siciliani del Messinese, diversi da quelli del resto dell’Isola. “Nei messinesi l’indole isolana appare in certo modo ammorbidita e levigata; l’animo loro si apre più facilmente con gli stranieri, le loro maniere sono più cerimoniosamente cortesi, il loro stesso dialetto è più largamente mescolato di vocaboli e di forme importate e meno sicilianamente accentuato che il dialetto delle altre popolazioni dell’Isola. Un indizio della mescolanza del sangue di questa città è il numero notevole dei biondi che vi incontra”. Queste osservazioni lo portano poi a riflettere che in Sicilia, generalmente, “l’uomo , dotato di facoltà intellettuali e morali ammirabili, è capace di far miracoli; ma gli uomini, renitenti all’associazione e ai sacrifici che la concordia impone, sono collettivamente inetti e infecondi” per cui il siciliano va conosciuto individualmente; ed allora, dice il De Amicis, che il singolo siciliano, “lavoratore, ragionatore, padre di famiglia, amico, ospite, si rivela tutt’altro uomo da quello che pare visto da lontano, nella moltitudine”. Maggiori attenzioni alla Città, urbanisticamente intesa, sono riservate a Palermo: “Palermo è la città di Sicilia che fece una più meravigliosa crescita dopo il years 1700poter essere di due milioni di abitanti. Ma i nuovi quartieri eleganti, le nuove vaste piazze alberate, i nuovi magnifici passeggi pubblici, veri luoghi di delizie, degni di Parigi e di Londra, non hanno mutato la sua antica fisionomia originalissima che è sempre costituita dalle due interminabili vie dritte, Macqueda e Vittorio Emanuele, che s’incrociano nel suo centro; e la sua bellezza caratteristica è sempre quel centro, quella piazzetta ottagonale dei Quattro cantoni, che hanno quattro architetture uguali d’ordine dorico, ionico e composito, coperte d’arabeschi e di fregi, ornate di fontane e di statue: piazza, mercato, foro e cuore di Palermo”. La folla dei palermitani, commercianti e sfaccendati, ricchi e poveri, spettacolo di violenti contrasti, si diffonde da quel centro verso le periferie; verso il Foro Italico: “vero passeggio di sovrani”, verso la Cala, affollata di brigantini, di paranze, di barcacce d’ogni specie: siciliane, napoletane, pugliesi, greche; verso l’Albergheria, dove brulica, ahimè, “una popolazione poverissima in migliaia di fetidi covi, che sono ancora quei medesimi in cui si pigiavano gli arabi di nove secoli orsono”. E l’occhio critico dell’uomo del Nord si spinge a considerare il Teatro Massimo, “il più grande e splendido teatro d’Italia, che costò otto milioni e di cui fu decretata la costruzione quando Palermo non aveva ancora un ospedale che rispondesse ai più stretti bisogni” e al triste spettacolo, visibile dal centro cittadino, elegante e movimentato, della partenza dei piroscafi che portavano via ogni settimana un popolo di emigranti verso le Americhe. Ma la descrizione di Palermo non poteva che chiudersi rivisitando i luoghi in cui aveva lasciato sue tracce Garibaldi: la piccola casa della Fieravecchia dove egli passò la prima notte dopo l’entrata a Palermo; il Palazzo Pretorio da dove annunziò al popolo d’aver respinto le proposte di armistizio avanzate dai generali borbonici, e la Kalsa d’onde proclamò la celebre frase: “o Roma o morte !”e la casa di Romagnolo, del sindaco Ugo delle Favare, dove risiedette nel 1882, l’ultima volta che venne a Palermo, vecchio e malato, poco tempo prima di morire, per le solenni celebrazioni del compimento del sesto secolo dal Vespro siciliano. Catania emerge dalle parole di De Amicis elegante, laboriosa, ricca di industrie e di una antica università e pure dotata di molti istituti di beneficenza; ma quello che commuove l’Autore pare siano la presenza dello spirito di Vincenzo Bellini (le cui spoglie erano state trasportate da Parigi nella cattedrale di Catania nel 1876) e le figure di due personaggi del tempo: l’attore dialettale Giovanni Grasso ed il poeta Mario Rapisardi, col quale ultimo, ormai malato, l’autore intrattenne una cordiale conversazione, piena di nostalgia per il tempo in cui avevano insieme combattuto per l’unità della Patria. Quindi la suggestività della descrizione della ferrovia circumetnea che, girando intorno al vulcano Etna, ricongiungeva già, nel 1895, 38 comuni. La parte del viaggio che suscita i più emozionanti richiami della Storia è quella riguardante Siracusa, città certamente ridotta nell’ampiezza urbana da quella che fu la città più grande del mondo greco ma ancora potente nella forza evocativa del suo passato, cui un amico aveva indotto il nostro Autore quando, salutandolo, gli aveva detto: “Vada sull’altura di Epipoli e volga in giro lo sguardo: vedrà venire sul mare Jonio le centotrentaquattro triremi di Nicia e di Lamaco. Vedrà arrivare dal Sud le flotte dei cartaginesi e Imilcone ed Amilcare rizzar le tende sulle rive dell’Anapo… vedrà venire dal Nord la flotta di Marcello, e i romani scalare dal porto di Trogilo le muraglie di Tiche, ed invadere Neapoli e l’Epipoli, e gettarsi nell’Ortigia presso la fontana Aretusa…e sentirà passare nell’aria l’ultimo sospiro di Archimede”. Sublimi sono le altre descrizioni che inducono il nostro Autore ad esaltare la Sicilia: “Quanti italiani, che hanno corso il mondo per diletto morirono o moriranno senza averti veduta!” Giuseppe Palmeri
Ricordi d'un viaggio in Sicilia
-
Autore:
-
Curatore:
-
Editore:
-
Collana:
-
Anno edizione:1999
Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.
Le schede prodotto sono aggiornate in conformità al Regolamento UE 988/2023. Laddove ci fossero taluni dati non disponibili per ragioni indipendenti da Feltrinelli, vi informiamo che stiamo compiendo ogni ragionevole sforzo per inserirli. Vi invitiamo a controllare periodicamente il sito www.lafeltrinelli.it per eventuali novità e aggiornamenti.
Per le vendite di prodotti da terze parti, ciascun venditore si assume la piena e diretta responsabilità per la commercializzazione del prodotto e per la sua conformità al Regolamento UE 988/2023, nonché alle normative nazionali ed europee vigenti.
Per informazioni sulla sicurezza dei prodotti, contattare productsafety@feltrinelli.it