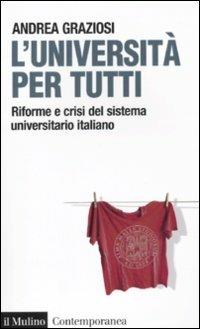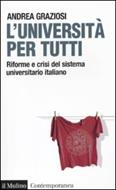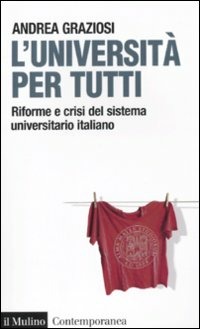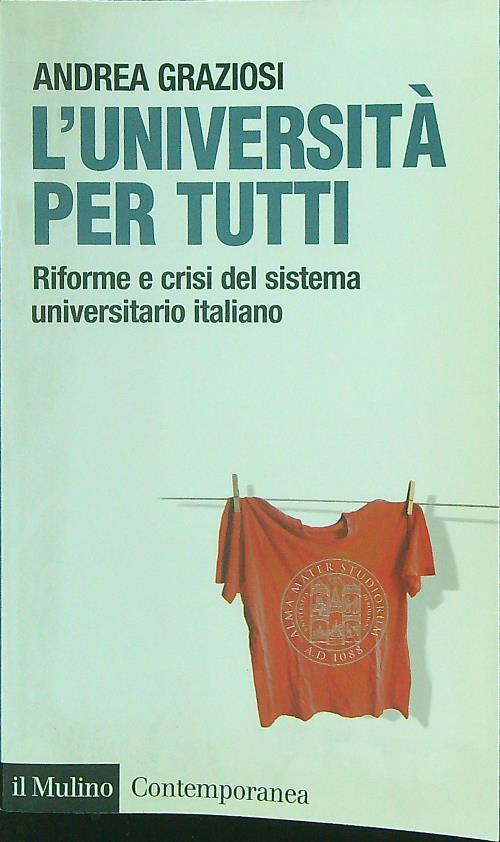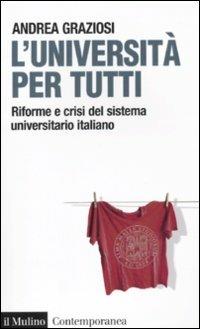Le università italiane figurano ormai nelle posizioni medio-basse delle graduatorie internazionali, e questo oggi non può certamente portare alla nascita di soluzioni estreme e quanto meno controverse. Se da un lato bisogna cercare una soluzione per il futuro, dall'altro bisognerebbe dapprima capirne le cause che negli anni hanno portato all'attuale "sistema Università". L'opera di Graziosi, professore di Storia contemporanea all’Università “Federico II” di Napoli, parte da questo presupposto e cerca di far chiarezza sulle scelte che ne hanno influenzato l'evoluzione, più obbligata che voluta, e sui provvedimenti e le varie riforme che hanno trasformato la vecchia università italiana di élite in una grande (grossa) e indistinta università di massa, provincializzata, succedutesi senza tener conto di quelle caratteristiche preziosissime quali la qualità e l'eccellenza. Sintetizzando un po' di storia, infatti, è sufficiente partire dagli anni '80 per rendersi conto di come l'università sia stata vittima di provvedimenti urgenti, tardivi e sbagliati, basati per lo più su scelte di opportunismo politico-sindacali. Basti pensare, ad esempio, che le risorse finanziarie agli atenei venivano assegnate in base al numero di iscritti e che migliaia tra precari, assistenti e incaricati vennero stabilizzati e promossi a docenti senza sostenere nessun tipo di concorso. Questi piani hanno portato negli anni come unico obiettivo il solo sviluppo quantitativo e dequalificato del sistema. Con l'autonomia degli anni '90, definita da Graziosi "una grande esperienza di autogestione", non regolata da alcuna assunzione di responsabilità da parte di ciascun ateneo ed avvenuta soprattutto senza un ripensamento degli organi di governance, si ebbero inoltre implicazioni devastanti che portarono all'aumento delle spese dovute al costo del personale docente e non, arrivato fino al 90% dei finanziamenti. L'irresponsabilità che hanno avuto certi professori (i cosiddetti "baroni") e di chi avrebbe dovuto controllare va quindi giudicata all'interno di questo contesto e delle sue logiche. Di conseguenza, a vedere i dati sul finanziamento pubblico degli atenei e sulla spesa per studente, le polemiche sui tagli di questi anni sembrerebbero solo uno strumento retorico con cui l'Università stessa è riuscita a farsi finanziare le sue inefficienze, a causa soprattutto di una cattiva distribuzione delle risorse. L'ordinamento del 3+2, voluto dal ministro Berlinguer, i suoi continui ritocchi e le sue pretese di "professionalizzazione" dei corsi, è arrivato infine a snaturare la vocazione e l'essenza stessa dell'Università, centro di alta cultura, abbassando ulteriormente il suo livello qualitativo e senza risolvere minimamente il problema del numero elevato degli studenti fuoricorso che ci si era proposto di fare. La storia degli ultimi anni è diventata così quella di un ministero che ha cercato di rimediare alle conseguenze sgradevoli e inattese (seppur prevedibili) delle sue scelte, che hanno provocato un forte aumento dei costi nella decisione implicita di far lievitare il numero di iscritti, docenti e corsi. Con Mussi si arriva persino al cosiddetto "pacchetto serietà". Il disegno di legge Gelmini, anche su pressione delle direttive europee, sembra per la prima volta tener conto in modo deciso del problema della qualità dei docenti e degli studenti del sistema universitario ed è per certi versi innovativo, anche se continua a trattare il sistema in modo egualitario. Cambiare tuttavia richiede tempo e denaro, e il primo obiettivo dovrebbe quindi essere quello di migliorare l'uso delle risorse già oggi disponibili e di spostare una parte di esse verso i settori migliori e quei centri dove la ricerca è la prerogativa. Giustissima, infine, l'osservazione di Graziosi riguardo alla tesi sbagliata, diventata oggi un luogo comune, secondo cui gli studenti siano gli utenti finali dell'università, i suoi cosiddetti "consumatori" (non più quindi Università degli studi ma «Università degli studenti») e quindi avrebbero il diritto di partecipare alla sua gestione: «l'utente finale dell'università è invece la società nel suo complesso, in cui gli studenti sono i beneficiari che dal titolo di studio riceveranno migliori condizioni. Andrebbe quindi semmai aumentata la possibilità di scegliere atenei migliori, rafforzando la loro partecipazione a organi di controllo sul comportamento dei professori o di efficienza del personale amministrativo». (www.giovannideluca.net)
L' università per tutti. Riforme e crisi del sistema universitario italiano
Prezzo minimo ultimi 30 giorni: 11,05 €
Le università italiane sono assenti dai posti alti nelle graduatorie internazionali, sono carrozzoni giganteschi, spesso sull'orlo del fallimento, culturalmente provinciali ed emarginate. Come si è precipitati in questa situazione e che cosa si può fare per uscirne? La lucida e stringente analisi di Graziosi ripercorre cinquant'anni di riforme e mutamenti che hanno trasformato la vecchia università di élite in una grande e indistinta università di massa, che era indubbiamente necessaria alla moderna società italiana, ma che si è gettata alle spalle ogni esigenza di eccellenza e di ricerca. Interessi corporativi e buone intenzioni si sono spesso saldati nel risultato perverso di produrre un degrado progressivo della formazione universitaria. A questa situazione, sostiene l'autore, è urgente porre rimedio con una serie di cambiamenti che mirino a separare fortemente le funzioni dello studio universitario, distaccandone l'istruzione professionale, differenziando gli atenei, e incentivando e sostenendo le eccellenze.
-
Autore:
-
Editore:
-
Collana:
-
Anno edizione:2010
Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.
-
GIOVANNI DE LUCA 23 agosto 2010
Le schede prodotto sono aggiornate in conformità al Regolamento UE 988/2023. Laddove ci fossero taluni dati non disponibili per ragioni indipendenti da Feltrinelli, vi informiamo che stiamo compiendo ogni ragionevole sforzo per inserirli. Vi invitiamo a controllare periodicamente il sito www.lafeltrinelli.it per eventuali novità e aggiornamenti.
Per le vendite di prodotti da terze parti, ciascun venditore si assume la piena e diretta responsabilità per la commercializzazione del prodotto e per la sua conformità al Regolamento UE 988/2023, nonché alle normative nazionali ed europee vigenti.
Per informazioni sulla sicurezza dei prodotti, contattare productsafety@feltrinelli.it