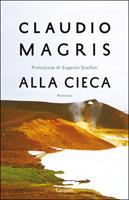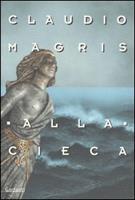Le prime frasi del romanzo:
1.
Caro Cogoi, a dire il vero non sono sicuro, anche se sono stato io a scriverlo, che nessuno possa raccontare la vita di un uomo meglio di lui stesso. Certo, quella frase ha un punto di domanda; anzi, se ricordo bene - sono passati tanti anni, un secolo, il mondo qui intorno era giovane, un'alba umida e verde, ma era già una prigione - ho scritto per prima cosa proprio quel punto interrogativo, che si trascina dietro tutto. Quando il dottor Ross mi ha incitato a stendere quelle pagine per l'annuario, mi sarebbe piaciuto - e sarebbe stato onesto - mandargli tanti fogli con un bel punto interrogativo e basta, ma non volevo essere scortese con lui, così benevolo e gentile, a differenza degli altri, e poi non era il caso di irritare uno che ti può togliere da una buona nicchia, come la redazione dell'almanacco della colonia penale, e spedirti nell'inferno di Port Arthur, a prenderti il gatto a nove code sulla schiena se solo per un attimo, sfinito da quei massi e dall'acqua gelida, ti siedi per terra.
Dunque ho messo davanti a quel punto di domanda soltanto la prima frase, anziché tutta la mia vita, mia, sua, di chissachì. La vita - diceva Pistorius, il nostro maestro di grammatica, accompagnando con gesti rotondi e pacati le citazioni latine in quella stanza tappezzata di un rosso che la sera s'incupiva e si spegneva, brace dell'infanzia che ardeva nel buio - non è una proposizione o un'asserzione, ma un'interiezione, un'interpunzione, una congiunzione, tutt'al più un avverbio. Comunque mai una delle cosiddette parti principali del discorso - «Sicuro che dicesse proprio così?» - Ah... sì, dottore, può darsi, forse non era lui a usare quest'ultima espressione, doveva essere la maestra Perich poi Perini, a Fiume, ma più tardi, molto più tardi.
Quella domanda iniziale del resto non può essere presa sul serio, perché contiene già la risaputa risposta, come le domande che si fanno ai fedeli in un sermone, alzando il tono della voce. «Chi può narrare la vita di un uomo meglio di lui stesso?» Nessuno, si capisce, sembra di sentire il mormorio della gente che risponde al predicatore. Se c'è una cosa cui ho fatto l'abitudine, sono le interrogative retoriche, fin da quando, nelle prigioni di Newgate, scrivevo i sermoni per il reverendo Blunt, che me li pagava mezzo scellino l'uno e intanto giocava a bastone con la guardia, aspettando che venissi a giocare anch'io, così si riprendeva spesso quel mezzo scellino - niente di strano, ero là dentro anche perché avevo perso tutto al gioco.
Ma almeno là, in quella cella, mentre le scrivevo davanti a quei muri lerci, ero io a formularle, quelle domande fasulle, anche se era poi il reverendo a sbraitarle dal pulpito, mentre altrove, dappertutto, prima e dopo, per anni e anni e saecula saeculorum me le hanno gridate nelle orecchie, «Dunque quel pandemonio in Islanda lo hai combinato tutto da solo, così, per amore di quella povera gente rachitica e tignosa, senza che nessuno ti desse una mano a mettere a soqquadro l'ordine dei mari di Sua Maestà, vero, allora hai sputato senza pensare che eri là in fila con gli altri ad ascoltare il discorso del nuovo comandante del penitenziario», e giù col gatto a nove code, «così non riconosci quella faccia di comunista, non l'hai mai vista e quei volantini te li sei trovati in tasca per miracolo», e giù calci e bastonate, «allora non sei una spia, un traditore venuto a sabotare, fingendo di essere un compagno, la libera Jugoslavia socialista dei lavoratori, magari sei un porco fascista italiano che vuoi riprendersi l'Istria e Fiume», e giù con la testa nel buco del cesso o a correre più svelto che puoi tra le file dei galeotti, che mentre passi davanti devono pestarti più forte che possono e urlare «Tito Partija, Tito Partija!» - ma da dove vengono queste urla, che fragore, non sento più, di chi è quest’orecchio assordato rintronato messo fuori uso, dev’essere stata una bastonata e se qualcuno l’ha data qualcuno l’ha certo presa, io o un altro.