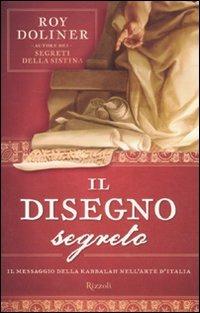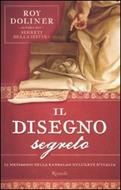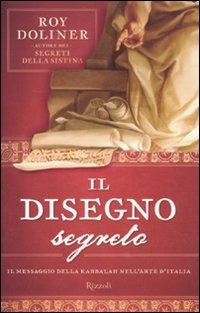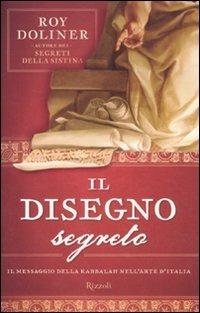Roy Doliner è un ebreo ortodosso che ha deciso di accattivare i goyim con un sorprendente miscuglio di aneddoti alquanto raffazzonati della storia e, in particolare, della storia dell’arte italiana, un bric-à-brac di dubbie “chicche” sui “segreti della Torà”, manifestazioni di amorevole premura per la salute materiale e spirituale della nazione italiana e appelli alla buona volontà altrui, per quanto riguarda codeste nobili preoccupazioni. Abbiamo a che fare, insomma, con un incrocio tra una specie di Dan Brown con la kippah, una versione arcimboldesca dell’eccellente (sia sempre lodato) Philippe Daverio e, per i tratti di filantropica saggezza da rotocalco, un esimio ariafrittologo alla Paulo Coelho. Titolo – Il disegno segreto – e sottotitolo – Il messaggio della Kabbalah nell’arte d’Italia – svelano sin dal principio la tesi perseguita dall’autore, e posso asserire che tra tali intenti programmatici e l’orchestrazione dei contenuti sviluppati nel libro non ci sono grandi discrepanze o soluzioni di continuità. Il primo grande, increscioso problema è che la tesi proposta e il titolo che la sintetizza sono strampalati, del tutto indifendibili. In effetti, non credo che ci sia stato alcun disegno segreto e, men che meno, che i grandi artisti tirati in ballo da Doliner si siano gioiosamente messi al servizio della trasmissione camuffata di un messaggio cabalistico. La tesi portante è dunque, secondo me, un rigoglioso esemplare di ircocervo fantastorico. La seconda magagna da segnalare riguarda la furbesca ma del tutto immotivata organizzazione del volume: suddiviso in undici capitoli, ognuno intestato ad una sefirà – undici, perché Doliner vi include Da‘at –, il rapporto stabilito, in ogni capitolo, tra la sefirà che dà loro il titolo e gli elementi storico-artistici ivi trattati è altamente discutibile, a dir poco; anzi, mi pare più giusto dirla arbitraria, forzata e cavillosa. Un particolare che ha a che vedere con le credenze proprie di alcune correnti dell’ebraismo, dal piglio non propriamente illuministico, è la tenacia con cui l’autore si attiene – religiosamente, è il caso di dire – «alla consuetudine di proteggere il santo nome divino non scrivendolo mai per esteso o correttamente». E poi esemplifica: «A volte scrivo una k al posto di una h [è quello che fa riguardo a Elohim, che trasforma in Elokim], a volte omettendo [sic] una vocale, come faccio con D-o e Sign-re» (nota a p. 152). Io lo trovo alquanto ridicolo, ma à chacun son goût, e poi ogni credenza sincera – se non lede i sacrosanti diritti umani – va semplicemente rispettata. Parlando di Corto Maltese, l’autore ci svela, a p. 237, che il nome di questo famoso personaggio di Hugo Pratt «rinvia all’enigmatica isola che fu una base dei cavalieri templari». I templari, a Malta? E io che pensavo fossero stati gli ospedalieri... O sono io che sbaglio, o allora è il Doliner che riesce a far più danni di Dan Brown. Perché non manchi proprio nulla al gioco di prestigio montato dall’autore, le pagine finali indugiano pure in un filantropismo-mecenatismo che non può non risultare gradito a tutti gli amanti del patrimonio artistico italiano. In questo ambito, spiccano i suoi accorati appelli alla ricostruzione della «mistica [sic] città di Aquila» (p. 301), conditi con l’autopubblicità del suo personale impegno fattivo (vedi la nota a p. 306). Non ci risparmia neppure questa oligofrenica sfilza di consigli perbenistici e qualunquisti, degni di un Paulo Coelho lanciato a ruota libera in un’affollata conferenza stampa: «Indipendentemente dal fatto che viviate o no in Italia, potete fare la vostra parte per evitare che precipitiamo tutti nell’oscurità: lottando contro la corruzione nella vostra città, aiutando a ripristinare una parte del vostro retaggio storico o culturale; dando vita a un gruppo di appassionati che leggano vere opere letterarie anziché libri da ombrellone; iscriversi [sic] ad associazioni di amici dell’arte, della musica o della danza, o fare qualunque altra cosa che aiuti a sviluppare la nostra gadlut, il nostro più elevato sé spirituale» (pp. 306-7). Avrò senz’altro un cuore di pietra e sarò pure antipaticissimamente scettico, ma non riesco proprio a raccogliere l’invito a «far parte della catena millenaria del movimento di mistici [eccoli di nuovo, e dappertutto, come i funghi in autunno] invisibili e non organizzati [,] intenti (…) a innalzare il mondo materiale verso lo spirito» (p. 308). Tutte queste spatafiate buoniste si inseriscono nel tessuto del libro come i cavoli a merenda – e, almeno per quanto mi riguarda, tali furbesche manovre di captatio benevolentiae hanno un effetto francamente controproducente. Nonostante tutto, mi ha fatto piacere trovare a p. 145, a proposito di Modigliani, un riferimento a quel fecondo pensatore livornese, Elia Benamozegh, che tanto si è sforzato per fare uscire l’ebraismo dal suo isolazionismo oltranzista, per spingerlo verso l’acquisizione di una decisa impostazione ecumenica – insomma, per farlo diventare una vera e propria religione universale. Secondo Benamozegh, l’allargamento delle potenzialità salvifiche dell’ebraismo a tutta l’umanità potrebbe essere raggiunto attraverso l’accettazione generalizzata dei sette princìpi del noachismo; il quale consiste in una sorta di distillato dei 613 precetti dell’ebraismo, talmente sintetico, talmente degno del consenso di ogni persona di buona volontà e di sana ragione che esso può essere ritenuto, a buon diritto, una concrezione cristallina di veri e propri universali etico-religiosi. Meno male, dunque, che Doliner abbia adottato – bontà sua – questa avvincente prospettiva noachita che, secondo gli ebrei meno particolaristici, basterebbe a mettere i doni della grazia divina anche alla portata dei gentili che ci si conformino: se il «solido fondamento» di una sana vita spirituale, «per l’ebreo fedele alla sua tradizione», «è nei 613 precetti reperibili nella Torah», «per i non ebrei è ancora più semplice, non essendo indispensabile ubbidire nemmeno ai Dieci Comandamenti. Sono sufficienti le sette leggi universali contenute nella storia (…) di (…) Noè» (p. 307).
Il disegno segreto. Il messaggio della Kabbalah nell'arte d'Italia
Prezzo minimo ultimi 30 giorni: 8,80 €
Pochi secondi prima che una pioggia di cenere oscuri il cielo, qualcuno traccia su un muro un ultimo disperato messaggio: "Sodoma e Gomorra". Oltre mille anni dopo, un monaco crea sul pavimento di una cattedrale un enorme e sofisticato mosaico che racchiude una chiave d'accesso al sapere umano e a quello mistico. Trascorre un secolo e un monarca illuminato costruisce un'intera città sul modello dell'antica Gerusalemme, per opporsi al monopolio spirituale del papato, impegnando le menti migliori della sua corte nella realizzazione di un castello fantastico: un capolavoro di simmetria di cui ancora oggi non è chiara la finalità. Sembrano i tasselli di una trama romanzesca o storie di Paesi remoti, invece il teatro di questi avvenimenti è proprio l'Italia. Sono infatti innumerevoli le stranezze, i dettagli curiosi o inquietanti che riempiono le nostre città: la statua di un elefante che mostra i quarti posteriori a una chiesa, un reticolo di catacombe o un pozzo o un giardino dalle perfette geometrie, un santuario che incrocia l'immaginario religioso con quello macabro, una Torre di Babele nel cielo di Roma e molto altro ancora. Nel "Disegno segreto", che prosegue sul sentiero intrapreso nel suo primo bestseller sulla Cappella Sistina, Roy Doliner ci guida alla riscoperta dell'Italia e del suo patrimonio artistico e mistico. Individua aspetti nuovi e significativi di opere da sempre sotto i nostri occhi che non abbiamo mai del tutto compreso.
-
Autore:
-
Traduttore:
-
Illustratore:
-
Editore:
-
Anno edizione:2012
Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.
Le schede prodotto sono aggiornate in conformità al Regolamento UE 988/2023. Laddove ci fossero taluni dati non disponibili per ragioni indipendenti da Feltrinelli, vi informiamo che stiamo compiendo ogni ragionevole sforzo per inserirli. Vi invitiamo a controllare periodicamente il sito www.lafeltrinelli.it per eventuali novità e aggiornamenti.
Per le vendite di prodotti da terze parti, ciascun venditore si assume la piena e diretta responsabilità per la commercializzazione del prodotto e per la sua conformità al Regolamento UE 988/2023, nonché alle normative nazionali ed europee vigenti.
Per informazioni sulla sicurezza dei prodotti, contattare productsafety@feltrinelli.it