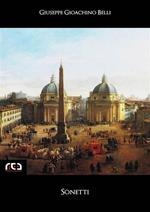Giuseppe Gioachino Belli (Roma 1791-1863) è stato un poeta italiano. La vita Dopo aver studiato al Collegio romano, rimasto presto orfano d’ambedue i genitori, ottenne modesti impieghi privati e pubblici. Intorno al 1810 iniziò la sua carriera letteraria e fondò con altri l’Accademia Tiberina, nel quadro della arretratissima cultura locale, divisa fra sonetteria arcadica e gusto dell’antiquaria. A venticinque anni sposò senza amore una ricca vedova, Maria Conti, dalla quale ebbe un unico figlio, Ciro. Raggiunta una discreta agiatezza, poté dedicarsi con maggiore impegno agli studi e alla poesia. Compì anche numerosi viaggi, a Venezia (1817), a Napoli (1822), a Firenze (1824) e a Milano (1827, 1828, 1829), stabilendo contatti con ambienti culturali più avanzati e scoprendo alcuni testi fondamentali della letteratura sia illuministica che romantica. Seguirono anni di felicità creativa (gli anni dei Sonetti romaneschi) e di timide aperture ideologiche. Nel 1828 si dimise dalla Tiberina e, con un gruppo di amici liberali, aprì in casa sua un gabinetto di lettura; ma dopo la morte della moglie (1837) ripiombò in gravi angustie economiche e morali. I successivi avvenimenti accelerarono il processo d’involuzione: la repubblica mazziniana del 1849 lo sconvolse, spingendolo nella schiera dei più accaniti difensori del trono e dell’altare, sicché quando, nel 1852, fu nominato censore della «morale politica» esercitò la carica con tanto zelo da condannare i melodrammi di Rossini e di Verdi, le tragedie di Shakespeare, le commedie di Scribe. Prima di morire, affidò i manoscritti dei Sonetti romaneschi all’amico monsignor Vincenzo Tizzani, con l’incarico di bruciarli; ma Tizzani li conservò e, dopo la morte del poeta, li consegnò, quasi integralmente, al figlio. I Sonetti sono 2279 e furono composti, per la maggior parte, in due fasi: 1830-37 e 1842-47. Vivente il poeta, ne furono stampati solo 23, ma uno solo col suo consenso (Er padre e La fijja). Un’ampia scelta (786), insieme a poesie in lingua, ne pubblicò il figlio Ciro, ma in un’edizione contraffatta per fini espurgativi (Poesie inedite, 4 voll., 1865-66); seguirono la raccolta, ancora incompleta, a cura di L. Morandi (6 voll., 1886-89), quella integrale, rivista sugli autografi, a cura di G. Vigolo (3 voll., 1952) e infine la raccolta completa curata da P. Gibellini, L. Felici ed E. Ripari (4 voll., 2018). Nell’accostarsi al capolavoro belliano il primo pregiudizio da rimuovere è quello che lo raffigura come una serie di stampe o di acquerelli alla maniera di Pinelli o di Thomas. La parte dei Sonetti che fa grande B. nulla ha in comune con il quadretto di genere, di tanta letteratura dialettale. B. scelse la vita del popolo come soggetto della sua opera, perché in una società, come quella romana del tempo, senza sbocchi culturali, dominata dalla corruzione e dalla ipocrisia, il popolano gli appariva, proprio per il suo stato di emarginazione, l’unico depositario della verità (una verità, com’egli dice, «nuda» e «sfacciata»). Discendere negli intimi recessi di quell’essere spontaneo che era il popolano di Roma significava per il poeta ritrovare l’impatto con la realtà, al di là di ogni mistificazione, e, quindi, scatenare le potenze represse del proprio spirito e della propria fantasia. Ma la discesa non fu mai gioconda e purificatrice, perché il primitivo di B. non ha i caratteri del «buon selvaggio» rousseauiano: è un personaggio condannato a una vita di sensi, di passioni sfrenate, che l’«altro B.», il «probo cittadino» devoto e conformista, non può tranquillamente assolvere. Di qui il doppio processo di attrazione e repulsione che la massa delle manifestazioni plebee ingenerano nell’animo del poeta, risolvendosi artisticamente nella forma dell’ironia e della comicità, la più adatta a rimescolare e oggettivare le insanabili antinomie di una avventura poetica ed esistenziale che non conobbe mai approdi catartici.La scelta del dialetto e il pessimismo belliano La discesa nel personaggio «popolo» comportava naturalmente l’adozione totale della sua parlata, e anche questa operazione fu per B. tutt’altro che indolore. Implicava anzitutto la condanna del lungo esercizio letterario dell’accademico tiberino, il ripudio di una «favella» illustre che B. stesso aveva definito «fradicia per quasi sette secoli di vita». La scelta del romanesco, inoltre, era tutt’altra cosa dalla scelta del meneghino, del veneziano o del napoletano, parlate comuni a tutti gli strati di quelle rispettive società, e quindi capaci di esprimere ogni tipo di contenuti, popolari e borghesi, istintivi o intellettualistici. Il romanesco, per un insieme di ragioni storiche, era invece un idioma esclusivamente subalterno, usato soltanto dalla plebe; sceglierlo significava dunque trasferirsi integralmente nelle strutture mentali e culturali della «turba», la quale è, secondo la stessa etimologia del termine, disordinata, incoerente, instabile. B. come nessun altro scrittore realista italiano, attuò in pieno questo difficile transfert, riuscendo a decifrare, nei Sonetti romaneschi, un’intera realtà, quanto mai varia e contraddittoria, attraverso le sole strutture del popolano. Quale realtà? Quella assurda, anacronistica, di uno stato teocratico in pieno secolo XIX: una piramide che al vertice ha il papa, il vicedio, il despota che «commanna e sse ne frega» (Er papa), che è «ssempre quello», da secoli, perché ne mutano le fattezze esteriori, ma l’anima «passa subbito in corpo ar zuccessore» (Er passa-mano); sotto di lui i cardinali, i prelati corrotti e prepotenti; alla base la plebe, vittima della sopraffazione dei ricchi, rassegnata o ribelle, onesta o ladra, che per dimenticare e dimenticarsi si rifugia in una religione di «smorfie», oppure si stordisce nei piaceri elementari del mangiare, del bere, del sesso. Particolareggiata in una infinità di caratteri e situazioni, questa è la «commedia romana» di B., la quale si dilata ben presto oltre i confini della città, coinvolgendo il destino di tutti gli uomini e il dio stesso che di quel destino è responsabile. Il dio belliano è il terribile tiranno che, dopo aver cacciato nell’inferno gli angeli ribelli, «stese un braccio/longo tremila mijja.../e sserrò er paradiso a ccatenaccio» (L’angeli ribbelli), è il Cristo che sulla croce sparse per i potenti «er zangue» e per i poveri «er ziere» (il siero), sancendo così la spaccatura in due dell’umanità (Li du’ggener’umani). Il confronto tremendo, faccia a faccia, del diseredato con la divinità è il filo conduttore che attraversa l’intera durata del poema belliano. Non di rado però la tensione drammatica si allenta e si aprono allora spazi per il divertimento puro, per l’effusione lirica o per il raccoglimento elegiaco. Sono momenti di tregua che variano, arricchiscono, ma non disperdono la fondamentale epicità dei Sonetti. Quantitativamente superiore a quella in dialetto la produzione poetica in lingua: l’edizione completa, in 3 volumi, è uscita soltanto nel 1975, col titolo Belli italiano. Più interessanti sono l’epistolario (Lettere, 2 voll., 1961; Lettere a Cencia, 2 voll., 1973-74), dove affiora qualche tratto dell’«umor nero» belliano; e lo Zibaldone (pubblicato in minima parte nel 1962), una raccolta di estratti e di indici di opere che documenta la conoscenza di illuministi e romantici italiani e stranieri, nonché un interesse assai vivo per la letteratura realistica, da Boccaccio fino a Berni e ai berneschi.