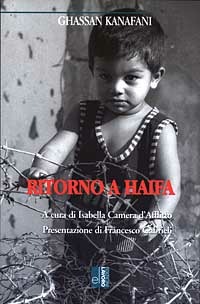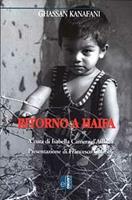Haifa, 21 aprile 1948. I colpi dei mortai giunsero inaspettati squarciando l'indefinibile tensione che regnava nell'aria, caos e terrore si impadronirono improvvisamente della città. I giovani sposi palestinesi Said e Safiya, paralizzati dalla sorpresa e dalla paura, vennero travolti dall'impetuosa corrente umana che si riversava verso il mare e non si resero conto di ciò che era successo finché gli spruzzi d'acqua sollevati dai remi della barca su cui erano stati caricati a forza non li ridestarono. Ma ormai era troppo tardi, la loro casa stava per diventare proprietà dell'Agenzia Ebraica, il loro bimbo di appena cinque mesi Khaldun era rimasto lì, nella sua culla, a piangere disperato. Haifa, conquistata dalle forze sioniste, scompariva dietro un velo di nebbia e di lacrime. Quasi vent'anni di esilio, poi la mattina del 30 giugno 1967 la coppia riesce a tornare per una fugace visita alla vecchia abitazione e, chissà, anche per ritrovare il figlioletto perduto. I nostri protagonisti bussano a quello che era il loro uscio e vengono accolti da una sconosciuta, Miriam, una ebrea polacca sfuggita alle persecuzioni naziste. Oltre alla loro casa la donna ha preso anche quel bimbo che piangeva nella culla, ma ormai non è più il piccolo arabo Khaldun, ora è il soldato israeliano Dov, per lui Said e Safiya sono solo due estranei, due che stanno dall'altra parte, gli arabi suoi consanguinei sono dei nemici da combattere in una guerra senza fine. Per tutto il racconto le lacrime scendono copiose dagli occhi di Safiya, che ha consumato la sua gioventù in attesa di questo momento, senza sapere che sarebbe stato un momento terribile. Sorrisi imbarazzati si affacciano sul volto di Miriam, che esprime comprensione e solidarietà per i suoi ospiti e al contempo professa tutta la sua innocenza. Parole dure e pesanti come macigni escono dalla bocca del ragazzo, i rimproveri e il risentimento verso i genitori carnali tacciati di vigliaccheria, arretratezza e paralisi suonano come un monito a tutti i palestinesi che forse non hanno lottato abbastanza per difendere la propria patria. L'apparente calma di Said è una buccia sottile che nasconde fiamme invisibili, il suo animo è acceso di rabbia impotente, la sua mente non riesce a spiegarsi come si possa approfittare così cinicamente delle debolezze e degli errori degli altri, come si possa pensare di porre rimedio all'ingiustizia con una nuova ingiustizia. Con inevitabile coinvolgimento emotivo e una prosa tagliente nei dialoghi e dolcissima nelle parti descrittive, Kanafani racconta la struggente storia di Said e Safiya che è la storia di un intero popolo, il suo popolo, chiamato a pagare colpe non sue, cacciato malamente dalla sua terra, costretto ad abbandonare le sue proprietà e brutalmente massacrato quando ha tentato di opporre la minima resistenza. È la storia di un'incancellabile umiliazione e di un'irreversibile perdita d'identità. È la storia di una serie di domande che esigono risposte che troppa gente non riesce o non vuole dare: può l'orrore della Shoah, per quanto enorme sia stato, giustificare la violenza, gli abusi e i soprusi che da decenni continuano a perpetrarsi nei confronti dei palestinesi? È giusto risarcire un popolo dei torti subiti a scapito di chi, di quei torti, non ha nessuna responsabilità? Può la comunità internazionale continuare a chiudere gli occhi mascherando la sua ingiustificabile inerzia dietro un'ipocrita maschera di avara carità?
Ritorno a Haifa
Poeta, scrittore, saggista palestinese, Kanafani racconta due diaspore: quella palestinese e quella ebraica, eccomunate da un unico, tragico destino. Said, palestinese di Haifa, torna con la moglie, dopo vent'anni di esilio, nella sua città natale per rivedere fugacemente i luoghi amati e la casa, ora abitata da una famiglia di ebrei polacchi scampati ad Auschwitz, e per cercare il figlio, abbandonato durante la repentina e tragica fuga. Con grande umanità e forza emotiva, Ghassan Kanafani ci accompagna in questo viaggio nel presente e nel passato, dove riaffiorano da entrambe le parti il disagio e la tristezza della situazione, in un groviglio di sentimenti e passioni umane.
-
Autore:
-
Curatore:
-
Editore:
-
Collana:
-
Edizione:3
-
Anno edizione:2003
Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.
-
Enrico Caramuscio 28 aprile 2014
-
SAMANTHA RUBINO 10 luglio 2008
Questo romanzo rientra in quella letteratura dell'esilio propria degli scrittori palestinesi che, sia dopo la nakbah del 1948, con la creazione dello Stato d'Israele, sia dopo la naksah del 1967, con la vittoria degli Israeliani nella guerra dei sei giorni, hanno sentito l'esigenza di raccontare lo stato d'animo, i sentimenti, il senso di perdita e sconfitta propri degli esiliati e dei profughi, nonché la delusione causata dall'insuccesso della costruzione della grande Ummah araba. Prende le mosse da pochi personaggi, quasi per tutta la narrazione sono soltanto due, per raccontare lo sconvolgimento di chi si trova allontanato dal proprio paese e vi torna dopo molti anni, solo per poco tempo. Il protagonista è Said: lui e sua moglie Safiya tornano ad Haifa, per una breve visita, dopo venti anni di esilio. In macchina, Safiya e Said parlano durante tutto il viaggio, passando da un argomento all'altro, pur di non affrontare la questione del loro ritorno. Si ammutoliscono solo quando arrivano in città. Le strade, le case, gli odori e, persino, gli alberi fanno emergere in loro un oceano di ricordi che sommerge le loro anime e sgorga dai loro occhi in forma di lacrime. L'autore elegge Said a voce narrante: egli racconta non solo i suoi pensieri e i suoi sentimenti, ma si fa interprete anche di quelli della moglie. Gli ritorna alla mente vivido il giorno della loro fuga: le bombe degli invasori, i colpi sparati dai difensori, la gente che grida e corre per le strade in cerca di salvezza, spingendo lui e sua moglie in quella fiumana di umanità che si dirige verso il porto. Invano entrambi cercano di resistere: lui vuole trovare sua moglie e suo figlio, mentre Safiya tenta di tornare a casa a prendere il piccolo Khaldum. Nella concitazione di quei momenti frenetici, quando Safiya si rende conto che non riuscirà a tornare da suo figlio, invoca il suo nome con urla strazianti, nome che non sarà pronunciato per i successivi vent'anni perché troppo doloroso sarebbe il pensiero del bimbo abbandonato, ma che le rimbomba senza sosta nella mente. L'invenzione poetica è paradossale e assurda: una madre che lascia in casa il figlio neonato, mentre dorme nella culla, per andare in cerca del marito durante un bombardamento non regge al controllo di credibilità, ma Kanafani adopera questo stratagemma per poter, successivamente, mettere a confronto due eventi catastrofici vissuti da due popoli tra loro nemici, da un lato l'olocausto e la diaspora degli ebrei verso la Palestina e dall'altro l'esilio dei Palestinesi dalla propria terra. Da una parte, infatti, ci sono Safiya e Said, strappati dalla loro casa, dalla loro terra e dalla loro vita, che hanno dovuto ricostruire un'esistenza altrove, in terra straniera, oppressi dal peso del senso di perdita e dallo spaesamento. Dall'altro c'è Miriam, arrivata ad Haifa con il marito, dopo che entrambi sono miracolosamente sfuggiti alla morte in un lager nazista, dalla quale non si sono salvati altri nove milioni di loro correligionari. In Palestina, questi due ebrei hanno trovato non solo una patria e una casa, ma anche un figlio, Kaldhum appunto. Kanafani pone sulla bilancia del racconto due vissuti, entrambi luttuosi e crudeli, dei quali uno è causa, indiretta e involontaria, dell'altro. Se è vero, infatti, che le prime idee sioniste nacquero già nei primissimi anni del secolo scorso1 e che, dopo la prima guerra mondiale2, ebbero un nuovo e più concreto impulso, con la creazione della Banca Nazionale Ebraica e del Fondo Nazionale Ebraico finalizzati all'acquisizione di terre in Palestina, è pur innegabile che, col genocidio perpetrato dai nazisti, la situazione è precipitata per la massiccia ondata di ebrei ex abrupto, provenienti dall'Europa, sul territorio. A causa della sua repentinità, gli arabi non sono riusciti ad elaborare tale fenomeno e, soprattutto, ad assorbirlo nel loro vissuto quotidiano e, quindi, ne sono diventati nemici. D'altro canto, questi profughi sono arrivati per scacciare un altro popolo dalla terra sulla quale ha vissuto per secoli, anzi per più di un millennio, rendendolo profugo a sua volta. A causa dell'esilio forzato dai territori occupati, provocato da Israele, gli arabi sono afflitti dal senso di estraneità e di alienazione, da quella ghurba ben descritta da Murid Al-Barghuthi, ma, a mio parere, per niente simile e paragonabile a quella dei loro antagonisti ebrei prima che tornassero in “terra santa”, dato che questi ultimi hanno abbandonato la loro terra d'origine più o meno volontariamente. Safiya e Said vengono accolti da Miriam in quella che prima era la loro casa. Sono circondati da ciò che un tempo gli apparteneva, da oggetti che raccontano di loro e della loro storia prima del disastro. Inaspettatamente, si rendono conto che l'abitazione, le sedie, i quadri e, persino, le sette penne di pavone, ormai ridotte a cinque, non sono più di loro proprietà, ma fanno parte di altre persone che si sono impossessate di una parte della loro vita. Al momento della fuga, avevano creduto che questa fosse solo momentanea, creduto al loro ritorno il prima possibile. Mentre, adesso, la dolorosa coscienza di aver perso tutto, anche quel figlio che non si chiama più Khaldum ma Dov, e che, addirittura, combatte contro di loro e il loro popolo nell'esercito israeliano, si abbatte sui due coniugi, che rimangono senza parole e che se ne vanno una seconda volta, ma questa convinti di non tornare mai più perché niente ormai li lega a quel posto. È un racconto emblematico della situazione dei Palestinesi, che vivono sparsi per il mondo in una situazione di perenne incertezza, ma con la speranza di tornare, prima o poi, alle loro case.
Le schede prodotto sono aggiornate in conformità al Regolamento UE 988/2023. Laddove ci fossero taluni dati non disponibili per ragioni indipendenti da Feltrinelli, vi informiamo che stiamo compiendo ogni ragionevole sforzo per inserirli. Vi invitiamo a controllare periodicamente il sito www.lafeltrinelli.it per eventuali novità e aggiornamenti.
Per le vendite di prodotti da terze parti, ciascun venditore si assume la piena e diretta responsabilità per la commercializzazione del prodotto e per la sua conformità al Regolamento UE 988/2023, nonché alle normative nazionali ed europee vigenti.
Per informazioni sulla sicurezza dei prodotti, contattare productsafety@feltrinelli.it